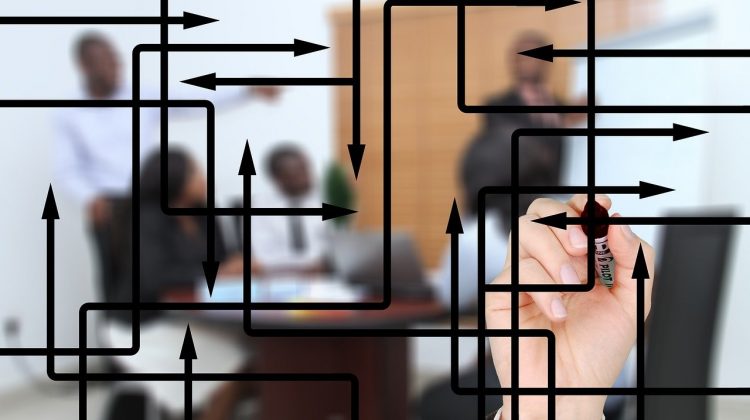
Gestione dei conflitti. Servono competenze e formazione interculturale
In un’epoca caratterizzata da una crescente globalizzazione e dalla formazione di società intrinsecamente pluralistiche e multiculturali, emerge con prepotenza una necessità: quella di affrontare e gestire in maniera efficace le dinamiche conflittuali che possono scaturire dalle diversità linguistiche e culturali.
Se è vero che le differenze sono un motore di opportunità, è altrettanto innegabile che esse rappresentano anche la radice di molti dei conflitti più acuti, sia nel passato che nel presente.
Tale complessità è ulteriormente accentuata dalla difficoltà di conciliare visioni del mondo differenti, come evidenziato dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948, che, pur nobile nelle sue intenzioni, mostra limiti significativi nella considerazione delle specifiche differenze culturali, quali il concetto indù di dharma o l’idea africana di ubuntu.
In questo scenario, la Mediazione Interculturale (MI) si configura come uno strumento fondamentale, ma la sua piena attuazione è spesso ostacolata da una diffusa carenza di competenze e formazione specifica, soprattutto nel contesto italiano, come rivelano alcune analisi settoriali.
Lo sottolinea Agostino Portera, ordinario di Pedagogia Interculturale all’Università di Verona, direttore del Centro Studi Interculturali e del Master in Intercultural Competence and Management.
Questo testo che stai leggendo è ricavato dal capitolo di Portera sulla “Mediazione Interculturale”, contenuto nel libro Manuale di Negoziazione e Mediazione, edito da Zanichelli, 2024.
La Mediazione Interculturale in Europa e in Italia
La mediazione è ampiamente riconosciuta come uno dei metodi più efficaci per la gestione dei conflitti, trovando applicazione in numerosi settori quali quello familiare, educativo, scolastico, giuridico, economico, medico-sanitario e politico internazionale.
In contesti multiculturali, i conflitti possono celare incomprensioni profonde, problemi di comunicazione e mancanza di informazioni, rendendo indispensabile un approccio che vada oltre la mera risoluzione superficiale.
A livello europeo, le istituzioni hanno individuato la mediazione interculturale come l’approccio più promettente per promuovere l’inclusione e facilitare la gestione dei conflitti in società sempre più eterogenee.
L’approccio interculturale, infatti, si distingue dagli interventi metaculturali, transculturali e multiculturali in quanto non si limita a riconoscere le differenze o a imporre modelli universali, ma considera identità e culture come entità dinamiche.
L’emigrazione e la vita in contesti pluralistici sono viste non solo come fattori di rischio, ma come opportunità di arricchimento e sviluppo positivo.
Questo approccio integra gli aspetti positivi dell’universalismo e del relativismo, promuovendo un’interazione autentica che implica il cambiamento di tutte le parti coinvolte attraverso il dialogo, il confronto e la risoluzione dei conflitti.
La MI, in tale ottica, supera la concezione statica e gerarchica della cultura, favorendo una riflessione aperta e la ricerca di accordi condivisi e duraturi.
Tuttavia, nonostante l’elevata importanza attribuita alla Mediazione Interculturale in Europa, emerge una notevole incertezza riguardo alla sua precisa definizione e alla sua strutturazione come professione.
Molti studi concettuali sembrano non basarsi su risultati e definizioni pregresse, né riconoscere lavori già pubblicati, denotando una frammentazione nel campo.
Sebbene la letteratura sulla MI in Europa si riferisca spesso alla mediazione linguistica e all’interpretariato, esistono contributi significativi anche in ambito giuridico, economico, sanitario, familiare e scolastico.
La mediazione e gli ostacoli in Italia
La transizione dalla teoria alla pratica rivela ancora molti limiti.
Una ricerca condotta in Veneto da Agostino Portera nel 2013 ha evidenziato diverse barriere istituzionali. E ha rilevato fattori critici che ostacolano la qualità della relazione e il successo nella gestione dei conflitti in ambito multiculturale, in particolare nei settori educativo, scolastico, giuridico, aziendale e sanitario.
Tra le principali barriere istituzionali riscontrate, spiccano:
- La mancanza di tempo per stabilire relazioni significative, dovuta alla fretta e ai molteplici impegni degli operatori, specialmente in ambito sanitario.
- La scarsa formazione o l’assenza del mediatore interculturale, una lacuna assai evidente nei contesti scolastici, giuridici e aziendali.
- La mancanza di formazione specifica alle competenze interculturali tra gli operatori.
Sono poi sono emersi fattori di criticità legati agli operatori:
- Scarse conoscenze linguistiche e culturali, che impediscono una comprensione profonda delle parti.
- L’adozione di metodologie obsolete, soprattutto frontali, che prediligono l’apprendimento mnemonico, specie nel settore scolastico.
- La persistenza di etnocentrismo, stereotipi e pregiudizi, che compromettono la possibilità di una conoscenza reciproca autentica, di un contatto efficace e di un’interazione costruttiva.
- Difficoltà strutturali e relazionali anche all’interno delle équipe di lavoro e nei rapporti con le famiglie di origine straniera.
Approfondendo l’analisi per settori specifici, la ricerca veneta rivela dinamiche peculiari:
- Settore scolastico: gli insegnanti tendono a privilegiare i contenuti cognitivi a discapito degli aspetti emotivi e relazionali. È stata rilevata una carenza di riflessività e, in alcuni casi, l’emergere di conflitti a causa di forme comunicative stigmatizzanti, stereotipi e pregiudizi. La scarsa formazione in MI contribuisce a mantenere metodologie didattiche obsolete.
- Ambito Giuridico: avvocati e giudici mostrano difficoltà significative nei rapporti multiculturali, in prevalenza a causa di una completa carenza di percorsi formativi specifici. Solo di recente è stata introdotta la figura del mediatore. I conflitti sorgono spesso a causa di barriere comunicative basate su differenze culturali, come ad esempio la percezione dell’approvazione di un giudice donna.
- Settore sanitario e aziendale: in questi ambiti, i conflitti sono di frequente causati dalla mancanza di una lingua condivisa (nonostante l’inglese sia spesso un lingua franca teorica), dall’impiego improprio di parenti (anche minori) per la traduzione – con il rischio di tradurre significati non corrispondenti all’intento comunicativo e di veicolare stereotipi e pregiudizi del traduttore stesso – e da un tempo limitato a disposizione degli operatori, a fronte di un’elevata quantità di compiti.
In tutti i settori indagati, la ricerca ha evidenziato un investimento scarso o del tutto assente nella formazione interculturale.
Molti professionisti, di conseguenza, incontrano difficoltà nell’identificare con chiarezza i compiti e i confini del proprio lavoro nel contesto della Mediazione Interculturale.
La formazione alla Mediazione Interculturale
Proprio quest’esigenza di formazione qualificata e di cambio di mentalità, in chi opera in situazioni multiculturali, ha portato il Centro Studi Interculturali dell’Università di Verona, diretto dal professor Portera, a insistere nell’organizzazione del Master in Intercultural Competence and Management – Mediazione interculturale, Comunicazione e Gestione dei Conflitti.
Il Master ha avuto inizio, in presenza, nell’anno accademico 2003-2004. Dal 2008 è passato a essere un Master online con tre seminari in presenza.
In questo modo, il corso si è posto come luogo di formazione interculturale leader in Italia.
Sono state circa 400 le persone formate – soprattutto donne – dal Master. Allieve e allievi sono venuti da mondi diversi: sociale, scuola, impresa, non profit.
L’importante, in questa fase, è che il mondo della formazione, il mondo dell’impresa e lo stesso mondo del sociale e delle istituzioni investa nella formazione delle proprie addette e dei propri addetti.
C’è bisogno di una formazione alla Mediazione Interculturale anche come spinta innovativa, per le organizzazioni, oltre che come competenza nella gestione dei conflitti, nel miglioramento delle relazioni interne ed esterne, nei contatti internazionali.
Articolo a cura di Maurizio F. Corte

