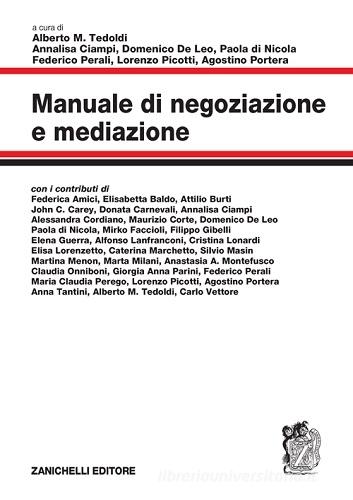Conflitti, aggressività e mediazione interculturale
La mediazione interculturale si fonda sulla comprensione dei meccanismi conflittuali, che emergono quando individui e gruppi con prospettive culturali differenti interagiscono.
Nel capitolo La Mediazione Interculturale, contenuta nel Manuale di Negoziazione e Mediazione (editrice Zanichelli), Agostino Portera mostra come i concetti di conflitto, rabbia e aggressività abbiano ricevuto un’attenzione crescente.
L’attenzione si è sviluppata solo in Psicologia, ma anche in Pedagogia e nelle altre Scienze Sociali, poiché la globalizzazione moltiplica le occasioni di scontro simbolico e materiale.
Il termine «conflitto», dal latino confligere, indica in modo letterale l’urto tra parti.
Tuttavia, la sua radice semantica di “mettere insieme” suggerisce anche un potenziale costruttivo, laddove il dissenso viene elaborato attraverso pratiche dialogiche.
Mediazione interculturale efficace
La mediazione interculturale, dunque, si colloca come risposta metodologica capace di trasformare l’energia aggressiva in un processo creativo di gestione dei conflitti.
Di mediazione interculturale si occupa il Master universitario in Intercultural Competence and Management – Mediazione interculturale, Comunicazione e Gestione dei Conflitti, diretto dal professor Agostino Portera e organizzato dal Centro Studi Interculturali all’Università degli Studi di Verona.
Nelle culture ad alto contesto comunicativo – Cina, Giappone, Corea – il contenuto verbale è spesso subordinato ai segnali non verbali.
Un semplice atto come mangiare con gusto segnala approvazione, mentre l’espressione diretta del dissenso può essere percepita come minaccia alla coesione del gruppo.
Al contrario, società a basso contesto – Germania, Svizzera, Scandinavia – privilegiano la verbalizzazione esplicita dei contenuti, richiedendo trasparenza e linearità argomentativa.
Questi codici divergenti generano con facilità fraintendimenti: silenzi che per un finlandese costituiscono segno di rispetto, possono essere vissuti da un italiano come ostilità latente.
La comunicazione interculturale
Per i professionisti della mediazione interculturale, la prima sfida è quindi l’alfabetizzazione ai “dialetti emozionali” che ogni cultura veicola. E quindi imparare a riconoscere le variabili paraverbali (tono, ritmo, pause) e i linguaggi corporei specifici.
La formazione deve includere analisi etnografiche dei sistemi di significato – ad esempio la categoria giapponese di wa (armonia) o quella africana di ubuntu (interdipendenza) – che influiscono sulle strategie di gestione dei conflitti.
L’intervento di mediazione – sottolinea Portera, che è ordinario di Pedagogia Generale all’Università di Verona – diventa efficace quando decodifica tali matrici e offre un vocabolario comune alle parti.
Si evita, in questo modo, la trappola universalistica che riduce le differenze a deviazioni rispetto a uno standard.
Gestione interculturale dei conflitti
Sul piano operativo la gestione dei conflitti integra tre momenti:
- emersione del dissenso latente,
- esplorazione delle narrative culturali che lo alimentano
- co-costruzione di soluzioni rispondenti ai bisogni di tutte le parti
Le tecniche includono l’ascolto attivo, la riformulazione semantica per dissipare ambiguità linguistiche, la negoziazione di significati simbolici (onore, vergogna, colpa) che possono scatenare reazioni aggressive.
Un mediatore interculturale – evidenzia Portera – è efficace quando bilancia empatia e neutralità, promuove l’eterocentration (Johnson & Johnson) e guida le parti verso il passaggio «dalla lotta alle soluzioni».
Maurizio F. Corte
* Coordinatore didattico e docente al Master in Intercultural Competence and Management
(Foto di copertina di Manuel Alvarez da Pixabay)